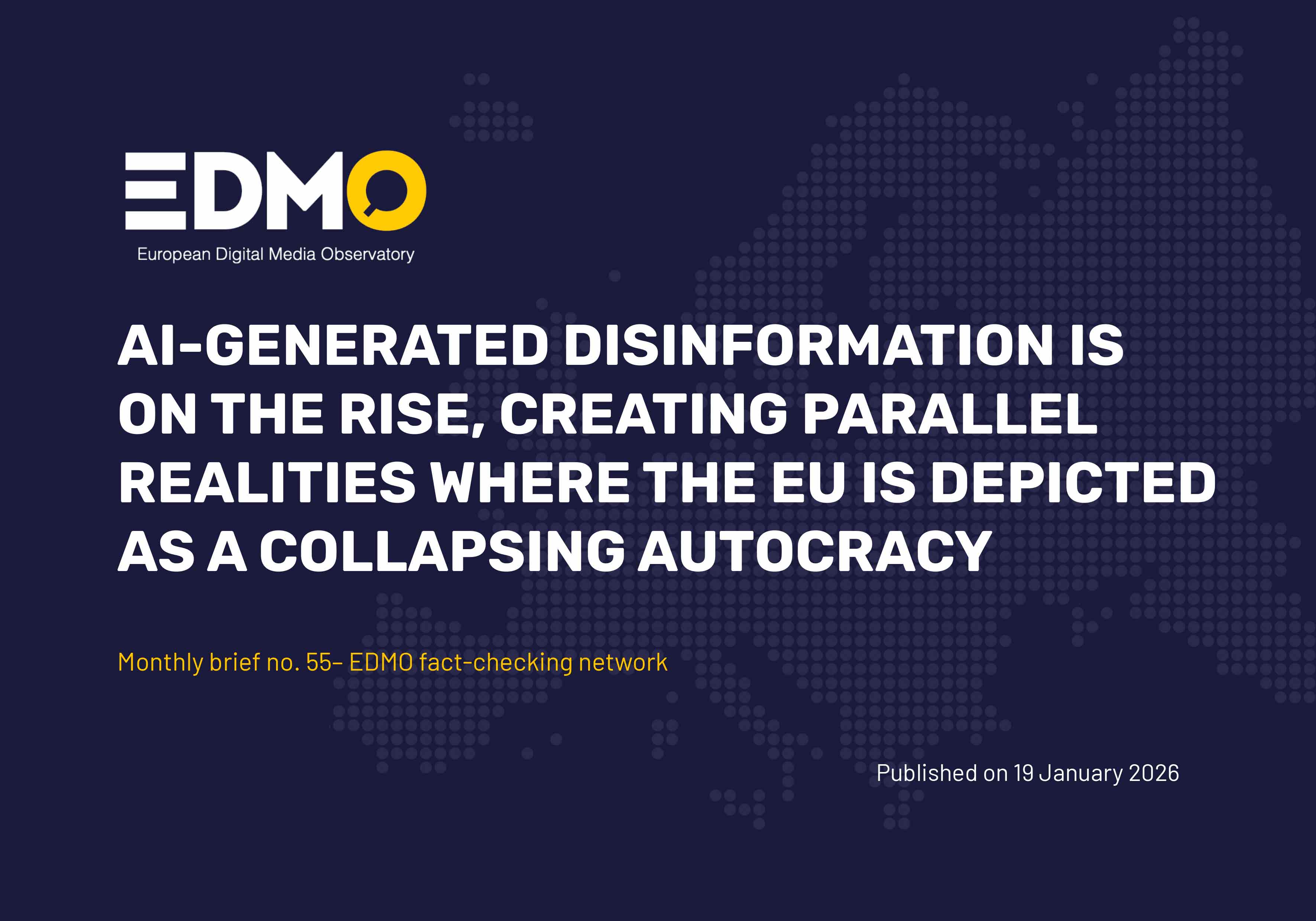In un mondo in cui i conflitti non si combattono solo con i carri armati ma anche con tweet, video e satelliti commerciali, l’intelligence sta cambiando volto. A dirlo è l’ultimo report del NATO Strategic Communications Centre of Excellence, con sede a Riga, che analizza un’evoluzione strategica delicata e sempre più centrale: l’uso dell’intelligence a fini di comunicazione pubblica, cioè come strumento per orientare percezioni, costruire consenso e influenzare comportamenti.
Il rapporto, a firma dell’analista svedese Niklas Nilsson, offre una mappa aggiornata di come governi occidentali, in particolare Stati Uniti e Regno Unito, abbiano progressivamente abbandonato il riserbo storico sulle informazioni sensibili per sfruttarle in modo selettivo nella guerra dell’informazione. L’evento spartiacque resta la vigilia dell’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, quando Washington e Londra diffusero pubblicamente dettagli operativi, piani militari e persino false flag preparate da Mosca, nel tentativo (fallito) di dissuadere il Cremlino e nel contempo compattare alleati e opinione pubblica.
Ma se l’operazione si è rivelata utile per consolidare il fronte euro-atlantico, il report non fa sconti sui rischi di questa nuova postura:
-Fonti e metodi a rischio: rendere pubblica un’informazione significa spesso bruciare una fonte o una capacità tecnica.
-Adattamento dell’avversario: una Russia o una Cina avvertita cambiano comportamento, eludono la sorveglianza, alzano il livello.
-Politicizzazione dell’intelligence: quando i governi chiedono “informazioni comunicabili”, si apre la porta a narrazioni più che ad analisi.
-Credibilità in bilico: se un allarme non si realizza, la fiducia crolla. L’Iraq del 2003 resta un monito ancora vivo.
Il documento sottolinea anche il ruolo crescente di attori non statali: organizzazioni investigative come Bellingcat o società private come Palantir producono oggi analisi che competono con quelle delle agenzie governative, spesso con maggiore rapidità e visibilità pubblica. Un cambiamento che costringe i servizi segreti ad accelerare, ma anche a muoversi su un crinale etico e operativo molto sottile.
Il caso ucraino è l’esempio più avanzato: Kyiv ha saputo usare l’intelligence in chiave narrativa – diffondendo intercettazioni, filmati di droni, prove di crimini di guerra – per rafforzare la coesione interna e ottenere supporto esterno. Ma l’efficacia di questa strategia dipende da un equilibrio instabile tra trasparenza e sicurezza, influenza e rischio.
Il messaggio finale è chiaro: nell’era delle guerre cognitive, l’intelligence non può più restare nell’ombra, ma deve stare attenta a non finire sotto i riflettori sbagliati. Se perde la sua neutralità, perde la sua funzione.